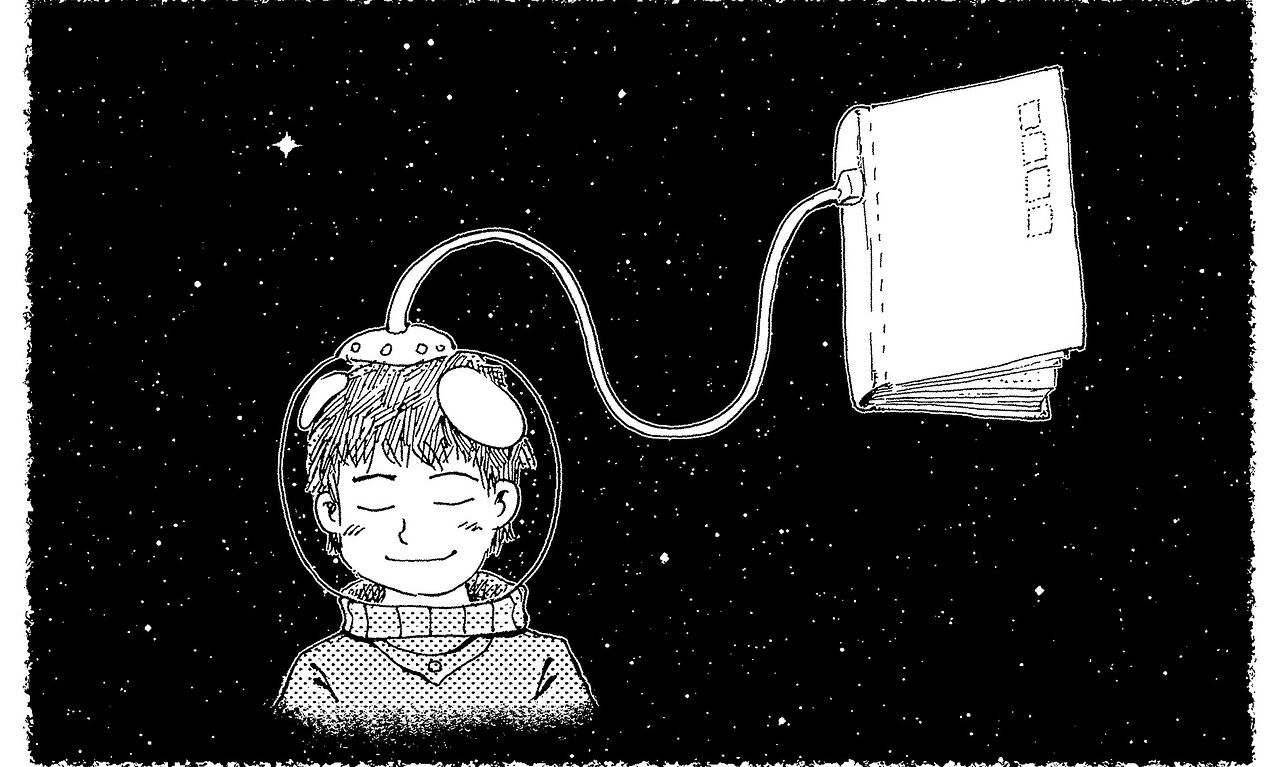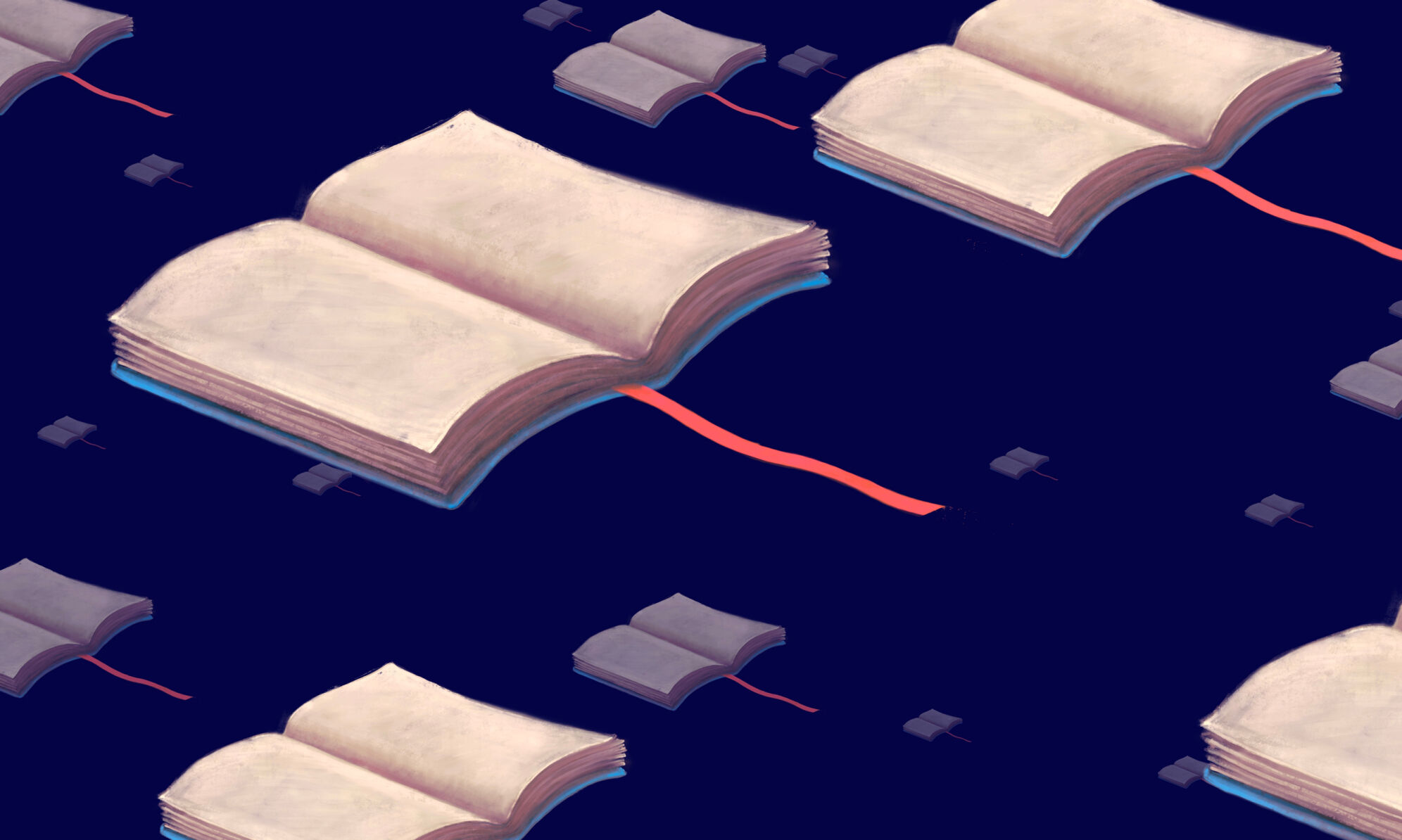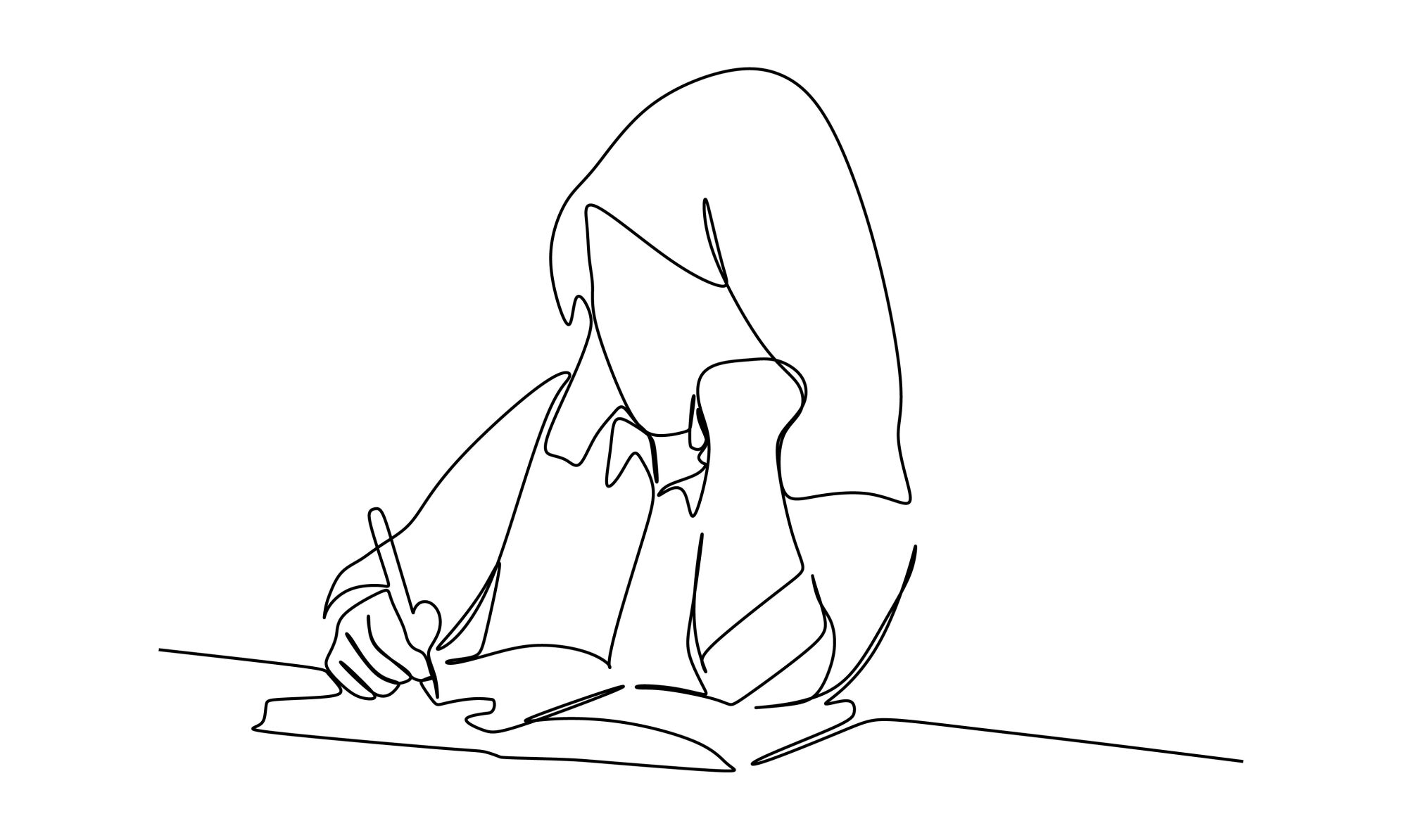La lettura spiegata con Cuore. Intervista a Marcello Fois
Già Istituzione Biblioteche di Roma; s.fabri@alice.it
Abstract
Un'intervista allo scrittore Marcello Fois sui valori trasmessi da uno dei classici della letteratura di formazione: Cuore di Edmondo De Amicis
English abstract
An interview with writer Marcello Fois on the values conveyed by one of the classics of coming of age novels: Cuore by Edmondo De Amicis
Abbiamo incontrato lo scrittore sardo, romanziere di successo e autore di alcuni saggi sulla lettura. Nel 2016 ha pubblicato per Einaudi un Manuale di lettura creativa e nel 2021, sempre per lo stesso editore, L’invenzione degli italiani: dove ti porta “Cuore”. Da questo suo ultimo libro abbiamo preso spunto per discutere su uno dei maggiori classici della nostra ‘letteratura di formazione’ e sui valori che l’opera di De Amicis trasmette.
Lei dice che De Amicis ha inventato gli Italiani: quindi un’operazione dettata non solo da esigenze letterarie ma anche da un preciso impegno etico-politico?
Direi che nel caso di Cuore è stata proprio l’assoluta professionalità letteraria di De Amicis a supportare un testo di chiara ed esplicita matrice etico-politica. Per questo motivo è divenuto comunque un classico. Un progetto civile scritto benissimo. Cuore, stilisticamente, non è paragonabile per scioltezza, ritmo, modernità, fluidità a nessuno dei testi coevi. Ha un italiano corrente e scorrevole, una lingua asciutta e chiara. E ha l’intento molto preciso di disegnare una Nazione che si regga sul rapporto tra l’istruzione e il senso civico. La straordinaria mescolanza di questi due ingredienti fa di Cuore quel prontuario etico e quel classico letterario che è.
De Amicis sembra buonista ma forse non lo è affatto: Cuore è un misto di sensibilità e di durezza?
De Amicis rappresenta, politicamente, una speciale visione del mondo, progressista e solidaristica, che caratterizza una certa fetta intellettuale illuminata dell’Europa alla fine dell’Ottocento. Un pensiero che è precisissimo nello stabilire che ogni società civile debba conformarsi attenendosi a una base improcrastinabile di diritti che debbono essere garantiti: cibo, istruzione, salute. E questo prima che la nostra Costituzione li sancisse come inalienabili. Una società classista e divisa come quella italiana più che impararli teoricamente attraverso testi come Cuore, li apprende nella pratica della narrazione. De Amicis oggi sarebbe ritenuto ‘buonista’ cioè generatore di pensiero piuttosto che portatore di verità. Nella classe di Cuore si fanno esperimenti di convivenza, non certo dimostrazioni di incompatibilità. Un modello che oggi da alcuni sarebbe considerato buonista proprio in virtù di quest’atteggiamento possibilista. I buoni hanno certezze che nel mondo di De Amicis non si coltivano. Quindi paradossalmente il termine ‘buonista’ che ha a che fare col dubbio, con la tolleranza, con la solidarietà non è affatto quell’insulto che molti ‘buoni’, troppo sicuri della propria verità, vogliono dare a intendere.
L’invenzione del personaggio di Franti a me sembra geniale. Lei che ne pensa?
Non più geniale di altri personaggi. Cuore si regge proprio sulla franchezza con cui le tipologie sono disegnate. Franti è un cattivo classico, come Gianciotto o Jago. Mostra e incarna una società che pretende di aver ragione senza argomenti. Rappresenta altresì il risultato di una società che non può accedere o che rifiuta l’istruzione. Una tentazione che attualmente pare avere la meglio. Direi che abitiamo in un Paese in cui Franti è persino entrato a far parte del nostro governo.
Cuore è uno dei dieci libri italiani più tradotti al mondo. In definitiva quale è la ragione più profonda? Quale è il pregio più segreto di De Amicis come scrittore?
Saper scrivere. Il che ormai pare secondario, ma resta il pregio principale di uno scrittore. Quello che lo distingue deontologicamente dall’esercito di scriventi che pure pubblicano, riempiono gli scaffali delle librerie e non di rado, istantaneamente, scalano le classifiche, per poi cadere in un dimenticatoio senza rimedio. De Amicis ha lo stesso pregio di tutti coloro che hanno portato avanti il loro compito con l’intento di perdurare, quindi, con la coscienza che per entrare a far parte della letteratura occorre innanzitutto la scrittura. Nessun segreto, dunque, solo quella dimestichezza nei confronti del proprio mezzo che permette di affrontare agevolmente qualunque progetto. L’opera di De Amicis è infatti ampia e complessa. I suoi scritti di viaggio, per esempio, sono davvero straordinari.
I nostri best seller per ragazzi, Le avventure di Pinocchio e Cuore, hanno qualcosa in comune?
La parentela, direi il debito genetico nei confronti di Manzoni. Da quella famosa riga alla fine dei Promessi sposi in cui Renzo Tramaglino rivendica di aver voluto che tutti i suoi figli sapessero imparare a leggere e a scrivere. Cuore e Pinocchio sono due espressioni di questo assunto. Nel primo si descrive una società utopica che ha nell’istruzione una condizione per esprimersi. Nel secondo un mondo distopico che ha rifiutato l’istruzione.
L’ammirazione di De Amicis per Dickens che significato potrebbe avere?
Direi la fiducia incondizionata nell’idea che una storia è magnifica solo a patto che si abbia una scrittura adeguata e viceversa. Gli scrittori di questa caratura dimostrano che l’autonomia della letteratura prescinda da qualunque moda o stagione e assume su di sé il principio che nessuna modernità, ciò che è, è inerte, ma deriva sempre da una lettura e da una competenza adeguate della tradizione, ciò che è stato.
In che senso Cuore è utopico?
Nel senso etimologico del termine. La classe prospettata da De Amicis, lo spazio cioè dove è possibile fare esperimenti di civismo, di tolleranza, di solidarietà, non esiste. È una forzatura narrativa necessaria perché si possa rappresentare un catalogo ampio di varianti. Il mondo rappresentato da Cuore è costruito su misura per le esperienze che si vogliono raccontare, come nella grande letteratura: la verità e la credibilità sono ottenute attraverso un duro e professionale artificio.
Mi ha colpito il paragone di Incompreso con la storia del Tamburino sardo, che per lei è un apice della scrittura di De Amicis. Ce lo spiega?
Il Tamburino sardo raccoglie l’apice delle capacità deamicisiane: è stato soldato, sa descrivere quella particolare guerra che ha caratterizzato la sua giovinezza, proprio come Lussu sapeva descrivere la Grande guerra o Mario Rigoni Stern la ritirata di Russia nella Seconda guerra mondiale. Un racconto non ‘borghese’ tutto interno all’esercito. Con un protagonista bambino che non sa concepire il sacrificio a cui è stato sottoposto. Il Tamburino sardo, nella lista dei piccoli eroi dei racconti mensili di Cuore, è l’unico a cui bisogna spiegare in cosa consistesse il suo sacrificio. È eroe a sua insaputa, non abbastanza conscio di sé da possedere il suo destino. Quando il Capitano gli annuncia il suo status di eroe ancora trasecola. Un modo azzeccatissimo di descrivere i sardi nel loro rapporto col Continente.
Perché il Nobel a Carducci invece che a De Amicis quando non c’è paragone tra la diffusione dell’uno con l’altro?
Domandarsi il perché dei Nobel è uno sport diffuso, ma piuttosto inutile: l’Accademia di Svezia decide per conto suo. La stessa domanda la si potrebbe fare per chiunque, a me spesso la fanno per Grazia Deledda.
Perché De Amicis amava Fogazzaro, anche lui più volte indicato per il Nobel senza successo?
Perché Fogazzaro è un narratore straordinario e schivo. Un personaggio che aveva a cuore un’idea di letteratura senza le forzature un po’ pompier del suo tempo. De Amicis riconosce in lui la caratura inattuale che vede in sé stesso. E questo nonostante l’immediato successo di vendite di Cuore.